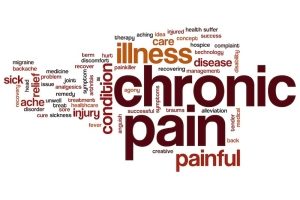Dolore Cronico e Depressione: lo Studio italiano sui Gemelli Svela un Legame “Quasi-Causale” Mediato dal Sonno e dal Benessere Soggettivo
Un nuovo e importante studio condotto in Italia dal Registro Italiano Gemelli (ITR), in collaborazione con Fondazione ISAL, ha utilizzato l’approccio genetico-epidemiologico per analizzare la complessa relazione tra Dolore Cronico non oncologico e i suoi substrati psico-socio-comportamentali. La ricerca, che ha coinvolto 750 coppie di gemelli monozigoti (identici) e dizigoti (fraterni), ha permesso di superare i limiti dei tradizionali studi osservazionali, riuscendo a distinguere l’influenza dei fattori genetici da quella dei fattori ambientali.
Lo studio, pubblicato sul Journal of Pain Research, ha fornito risultati di grande impatto clinico e scientifico: la comorbilità tra dolore cronico e sintomi depressivi è risultata essere un legame robusto, suggerendo una relazione di natura “quasi-causale”. Inoltre, i ricercatori hanno identificato due mediatori chiave che possono indirizzare nuove strategie terapeutiche: la qualità del sonno e la soddisfazione di vita.
Per approfondire il significato di questi risultati, abbiamo intervistato il Dott. Corrado Fagnani, primo autore dello studio e ricercatore presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), e il Dott. Michael Tenti, co-autore della ricerca, psicoterapeuta e membro della Fondazione ISAL per la Ricerca sul Dolore.
L’Intervista
Domanda (a Dott. Corrado Fagnani): Dottor Fagnani, la correlazione tra dolore cronico e depressione è nota, ma il vostro studio ipotizza una relazione di natura “quasi-causale”. Potrebbe spiegare meglio cosa significa esattamente questo concetto nell’ambito della ricerca sui gemelli?
Dott. Corrado Fagnani (ISS): L’elemento rivoluzionario del design sui gemelli è la capacità di tenere sotto controllo i fattori innati. Per “quasi-causale” intendiamo che il forte legame che osserviamo non è semplicemente dovuto al fatto che le persone con una predisposizione genetica alla depressione sono anche più predisposte al dolore. Per capirlo in modo semplice, abbiamo esaminato le coppie di gemelli monozigoti discordanti. Immagini due gemelli identici: hanno lo stesso DNA e sono cresciuti nello stesso ambiente familiare. Scientificamente, tutto ciò che è ereditato o condiviso è uguale per entrambi. In queste coppie, solo un gemello soffre di dolore cronico. Nonostante i fattori genetici e ambientali condivisi siano identici, abbiamo osservato che il gemello con il dolore cronico ha anche una forte associazione con i sintomi depressivi, mentre l’altro gemello no. Dato che la genetica non può spiegare la differenza tra i due, il legame che osserviamo deve essere attribuito a meccanismi che si sviluppano dopo la manifestazione del dolore stesso. È come se la sofferenza fisica del dolore cronico innescasse o scatenasse la depressione come conseguenza diretta, indipendentemente dalla predisposizione genetica condivisa. Questo rafforza l’idea che il dolore cronico non è solo un sintomo, ma un agente di danno alla salute mentale.
Domanda (a Dott. Corrado Fagnani): È notevole che il 73% della correlazione tra dolore cronico e depressione sia attribuibile a fattori ambientali unici individuali. Quali sono i risvolti di questo dato per la prevenzione e per le politiche sanitarie? E quali sono, a livello epidemiologico, i fattori non genetici che influiscono maggiormente su questa relazione?
Dott. Corrado Fagnani (ISS): Questo 73% è estremamente importante e rappresenta la nostra maggiore speranza d’intervento. Significa che, sebbene ci sia una piccola componente genetica (l’ereditabilità che abbiamo stimato per il dolore cronico è del 33% e per la depressione del 27%), la maggior parte del problema risiede in fattori su cui possiamo e dobbiamo agire: lo stile di vita individuale e gli eventi ambientali unici che solo un gemello ha vissuto. A livello epidemiologico, questi fattori includono l’esposizione a traumi specifici, fattori di stress lavorativi o sociali, e soprattutto le abitudini comportamentali. Dato che il sonno e la soddisfazione di vita sono i mediatori più forti che abbiamo identificato, le politiche sanitarie e i programmi di prevenzione devono spostarsi verso un approccio personalizzato focalizzato sul comportamento. Dobbiamo implementare strategie di salute pubblica che non solo mirino al trattamento del dolore, ma che supportino attivamente il miglioramento della qualità del sonno, promuovano l’attività fisica adattata e aiutino i pazienti a ricostruire un senso di soddisfazione e di scopo nella vita, agendo direttamente sui fattori che alimentano il legame tra dolore e depressione.
Domanda (a Dott. Michael Tenti): Il vostro studio identifica la qualità del sonno e la soddisfazione di vita come mediatori chiave nella relazione tra dolore cronico e sintomi depressivi. Quali implicazioni cliniche immediate e quali nuove strategie terapeutiche suggeriscono questi risultati?
Dott. Michael Tenti (Fondazione ISAL): I risultati della mediazione hanno implicazioni cliniche essenziali perché spostano l’attenzione da fattori immodificabili a fattori su cui possiamo intervenire. Abbiamo scoperto che l’effetto negativo del dolore cronico sui sintomi depressivi non è diretto, ma è indirettamente espresso attraverso due variabili: il peggioramento della qualità del sonno e la riduzione della soddisfazione di vita (o benessere soggettivo). In pratica, il dolore peggiora il sonno e riduce la percezione di benessere, e sono questi due elementi che, a loro volta, fanno aumentare i sintomi depressivi. Questo sottolinea il ruolo cruciale di questi fattori modificabili nella gestione della comorbilità. Di conseguenza, l’approccio terapeutico non può limitarsi solo alla riduzione del dolore farmacologica, ma deve essere rigorosamente multidisciplinare. Le nostre scoperte supportano l’inclusione sistematica di interventi psicologici mirati: ad esempio, terapie come la Terapia Cognitivo Comportamentale per l’Insonnia (CBT-I) hanno dimostrato di migliorare significativamente sia il sonno, sia il dolore, sia i sintomi depressivi nei pazienti con insonnia correlata al dolore. Allo stesso modo, interventi cognitivo-comportamentali e strategie basate sulla Acceptance and Commitment Therapy o sulla psicologia positiva, volte a rafforzare la soddisfazione di vita e il benessere emotivo, possono offrire benefici concreti. Integrare queste strategie nei percorsi di gestione del dolore è fondamentale per spezzare il circolo vizioso tra sofferenza fisica e mentale.
Per i lettori interessati, il testo integrale del paper, intitolato Psycho-Socio-Behavioural Substrates of Non-Cancer Chronic Pain: A Twin Study in Italian Adults, è disponibile qui: https://www.dovepress.com/psycho-socio-behavioural-substrates-of-non-cancer-chronic-pain-a-twin–peer-reviewed-fulltext-article-JPR