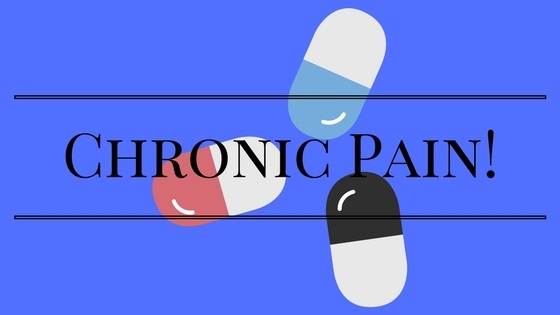Il dolore cronico in Italia: intervista alla dottoressa Toccaceli dell’Istituto Superiore di Sanità e ai ricercatori ISAL
Rimini, 6 novembre 2025
Un nuovo, fondamentale studio epidemiologico fa luce sulla reale prevalenza e sull’impatto psicosociale del dolore cronico nella popolazione adulta italiana. Il paper, pubblicato sull’International Journal of Environmental Research and Public Health, colma una lacuna informativa che durava dal 2003, fornendo il più aggiornato quadro nazionale.
Frutto della collaborazione tra Istituto Superiore di Sanità (ISS), ISTAT e Fondazione ISAL per la ricerca sul dolore, l’analisi si basa sui dati raccolti dall’European Health Interview Survey (EHIS) 2019 in Italia. Adottando la più recente definizione di “dolore cronico” fornita dalla International Association for the Study of Pain (IASP), che lo inquadra come un dolore che persiste da oltre tre mesi, l’indagine ha raggiunto un vasto campione rappresentativo di oltre 44.000 persone.
I risultati sono chiari e allarmanti: circa 10.5 milioni di adulti italiani, ovvero il 24.1% della popolazione, soffrono di dolore cronico. La prevalenza e l’intensità sono significativamente più alte tra le donne (28.1% vs 19.7% degli uomini) e aumentano drasticamente con l’età, superando il 50% tra gli over 75. Inoltre, quasi il 30% dei casi di dolore cronico è classificato come dolore di intensità severa o molto severa.
Per comprendere le profonde implicazioni di questi dati, abbiamo incontrato la Dott.ssa Virgilia Toccaceli, ricercatrice dell’ISS nonché coordinatrice del gruppo di lavoro interistituzionale ISS-ISTAT-ISAL per la ricerca sul dolore cronico, il Dott. Michael Tenti, psicoterapeuta di Fondazione ISAL, e il Dott. William Raffaeli, Presidente di Fondazione ISAL esperto nel campo della ricerca e cura sul dolore
L’Intervista
Domanda (a Dott.ssa Toccaceli): Dottoressa Toccaceli, questo studio rappresenta un punto di svolta. Quali sono le principali implicazioni per la ricerca e per le future policy sanitarie che emergono dai dati sul carico psicosociale del dolore cronico?
Dott.ssa Virgilia Toccaceli: I dati mostrano in modo inequivocabile che il dolore cronico è un onere psicosociale enorme. Non è solo un sintomo fisico, ma un fattore che determina svantaggio sociale e disabilità. Ad esempio, un dolore cronico di intensità severa aumenta di quasi cinque volte il rischio di avere difficoltà nella partecipazione sociale e di oltre quattro volte le assenze dal lavoro in un anno. L’aspetto più preoccupante, sul fronte delle disuguaglianze, è che il dolore cronico è nettamente più prevalente nelle persone con un basso livello di istruzione.
Le policy devono quindi evolvere. Devono non solo rafforzare l’assistenza specifica per il dolore, ma anche sviluppare interventi sociali e lavorativi mirati, per prevenire l’isolamento e la perdita di produttività. Il dolore cronico severo aumenta di quasi sedici volte la limitazione nelle attività quotidiane. È un problema di salute pubblica che richiede un approccio intersettoriale, andando oltre i soli interventi di tipo sanitario, per agire sui determinanti sociali.
Domanda (a Dott. Raffaeli): Lo studio ha evidenziato che quasi il 15% dei soggetti con dolore cronico non riceve alcun trattamento e un ulteriore 13.6% rimane senza una diagnosi specifica. Chi sono, dal punto di vista clinico, questi pazienti che non vengono curati? E quali sono i principali ostacoli all’accesso alle cure specialistiche del dolore?
Dott. William Raffaeli: Questo è forse il dato più critico e, allo stesso tempo, il più inaccettabile. I pazienti che non ricevono diagnosi o trattamento sono spesso quelli affetti da forme di dolore complesse, non immediatamente riconducibili a una lesione organica — come nel caso della fibromialgia — o non più correlabili a un danno fisico pregresso, come gli esiti di interventi chirurgici o traumi. La difficoltà principale nasce dalla mancanza di strumenti diagnostici in grado di identificare in modo oggettivo la presenza e la severità biologica del dolore, e di caratterizzarne le diverse tipologie. Nonostante la Legge 38/2010 abbia reso obbligatoria la rilevazione del dolore in tutte le strutture sanitarie italiane, la sua cura non ha ancora raggiunto lo stesso livello di attenzione. Accade così che, anche di fronte a un dolore severo e ribelle ai trattamenti, il paziente venga dimesso senza una presa in carico adeguata, privo di un piano terapeutico chiaro o di indicazioni precise sui centri specializzati a cui rivolgersi. Un problema analogo emerge anche nella medicina generale, dove il dolore è spesso sottostimato a causa della carente formazione universitaria e della limitata esperienza clinica nell’uso delle diverse opzioni farmacologiche disponibili. Questo genera confusione nel paziente e nella sua famiglia, con tempi lunghi di assistenza e un ritardo significativo nell’accesso a specialisti competenti dei centri di terapia del dolore o delle cure palliative.
Gli ostacoli all’accesso alle cure sono molteplici e stratificati. Il primo è il mancato riconoscimento del dolore cronico come patologia autonoma, alimentato da una formazione ancora lacunosa dei professionisti sanitari. A ciò si aggiunge la scarsa interdisciplinarietà del sistema: spesso il paziente è costretto a essere il “case manager di sé stesso”, passando da uno specialista all’altro senza un coordinamento reale. Vi sono poi le barriere legate alla ricerca: per alcune condizioni, come la fibromialgia, mancano biomarcatori oggettivi che consentano diagnosi certe. Anche i farmaci attuali, in molte forme di dolore, risultano solo parzialmente efficaci o gravati da effetti collaterali importanti, lasciando molte persone orfane di una cura soddisfacente. Infine, non possiamo ignorare gli ostacoli emotivi e culturali: la rassegnazione dopo anni di sofferenza, o il radicato stoicismo del “dover sopportare”, che ritardano la richiesta di aiuto.
Superare questa rete di barriere — come previsto dalla Legge 38/2010 — è una priorità assoluta. Solo un approccio realmente globale, integrato e multidisciplinare può garantire che la complessità del dolore venga finalmente compresa e curata nella sua interezza.
Domanda (a Dott. Tenti): Dottor Tenti, in qualità di psicoterapeuta, quali sono le implicazioni cliniche immediate e le sfide che emergono, soprattutto in relazione ai dati sulle comorbidità psicologiche?
Dott. Michael Tenti: I numeri confermano ciò che osserviamo ogni giorno in clinica, ma con una forza impressionante. La correlazione tra dolore severo e patologie mentali è drammatica: il rischio di soffrire di depressione o ansia cronica severa è circa sette volte superiore nei pazienti con dolore severo rispetto a chi non ne soffre. Questo evidenzia che il dolore cronico è una malattia complessa, che richiede un approccio multidisciplinare integrato. La sfida clinica è duplice: trattare il dolore in modo efficace e, contemporaneamente, gestire in modo proattivo le comorbidità psicologiche. Non possiamo più permetterci di curare solo il corpo, ignorando l’impatto sulla salute mentale. I servizi per la terapia del dolore devono includere stabilmente procedure di screening psicologico e di gestione interdisciplinare mediante collaborazioni con professionisti come lo psicologo e lo psichiatra.
Domanda (a Dott. Tenti): Lo studio rivela anche che i pazienti con dolore cronico utilizzano di più i servizi sanitari (medici di base, specialisti e procedure diagnostiche). Ma si nota anche una disuguaglianza nell’accesso alle cure per la salute mentale. Come si spiega?
Dott. Michael Tenti: È un paradosso doloroso. Chi soffre di dolore cronico severo ha una maggiore necessità di ricorrere ai servizi, consumando più risorse. Eppure, per la sottopolazione che ha già una diagnosi di depressione o ansia, il dolore cronico sembra ridurre l’accesso alle cure di salute mentale e aumentare la probabilità di rinunciare a esse per barriere economiche.
Questo indica che il nostro sistema sanitario non sta intercettando o gestendo adeguatamente la sfera emotiva e psicologica del malato cronico. La rinuncia per motivi finanziari, in particolare, solleva un problema di equità e di accesso che va affrontato con urgenza, garantendo che le cure psicologiche siano integrate e accessibili all’interno del percorso terapeutico per il dolore. Inoltre, non va dimenticato che ben il 14.8% dei pazienti non riceve alcun trattamento e il 13.6% rimane senza una diagnosi specifica. Questo è un fallimento del sistema che deve essere corretto attraverso la formazione e la sensibilizzazione.
Domanda (a Dott.ssa Toccaceli): Concludendo, Dottoressa Toccaceli, qual è il valore aggiunto di questa indagine in una prospettiva temporale, e quali sono i prossimi passi per l’epidemiologia del dolore?
Dott.ssa Virgilia Toccaceli: Il valore dei dati 2019 è cruciale perché rappresentano una baseline pre-pandemica. Poter disporre di un dato così solido ci permetterà, in futuro, di monitorare in modo rigoroso l’impatto della pandemia da COVID-19 e le sue conseguenze, dirette e indirette, sulla prevalenza e sulla gestione del dolore cronico nella popolazione italiana.
In termini di ricerca, dobbiamo intensificare il monitoraggio continuo: solo mantenendo un flusso costante di dati epidemiologici di qualità potremo supportare i decisori politici nella progettazione di un sistema di cura del dolore che sia efficace, equo e in grado di affrontare la complessità di questa malattia in crescita.